Carmen Andriani
Di Antonio Scelsi e Ferdinando Maria Tempesta
Carmen Andriani, nata a Roma nel 1953, ha completato la sua formazione laureandosi in Architettura sotto la guida di L. Quaroni a Roma nel 1980. A partire dal 1992, ha intrapreso la sua carriera come docente presso la Facoltà di Architettura di Pescara, distinguendosi per il suo impegno nella ricerca teorica e progettuale focalizzata sui fenomeni di dismissione infrastrutturale e patrimoniale. Il suo interesse si è particolarmente concentrato sulle città costiere e sui porti del Mediterraneo.
A partire dal 1996, Carmen Andriani assume il ruolo di caporedattore della rivista “Piano Progetto Città” del DAU di Pescara, contribuendo in modo significativo alla diffusione di conoscenze e idee nel campo dell’architettura. Inoltre, ha svolto il ruolo di visiting professor presso la Waterloo University di Toronto, condividendo il suo lavoro attraverso conferenze tenute in università sia italiane che americane.
Nel periodo 2009-2013, ha ampliato il suo campo di indagine a contesti medio-orientali, conducendo missioni in Libia, Giordania ed Egitto e affrontando con profondità il tema dell’archeologia in contesti estremi del deserto.
Carmen Andriani è stata selezionata nel 2008 tra i cinque invitati per il Padiglione Italiano alla XI edizione della Biennale di Architettura. Nel 2013, ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera per l’architettura nella prima edizione di ICASTICA ART EVENT, riconoscimento che sottolinea il suo contributo significativo al campo architettonico.
Tra i numerosi progetti di rilievo negli ultimi anni, spiccano: il percorso turistico-monumentale dalla piazza del Pantheon a Fontana di Trevi (primo premio, attualmente in fase di realizzazione); la sistemazione del prospetto della città di Teramo sulla valle del Tordino (premiato nel 1993); il recupero del Porto Corsini a Ravenna (1994); la riqualificazione del parco fluviale e del porto canale di Pescara; il parco tecnologico e la riqualificazione ambientale dell’area metropolitana di Rogoredo a Milano (Triennale di Milano, 1995); la riqualificazione del Borghetto Flaminio a Roma (1995); la mostra “L’architetto e l’artista a confronto su un tema emblematico: l’ampliamento di spazi e di funzioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna” (1997); il Centro delle Arti Contemporanee di Roma (1998); il Ponte dei Congressi (selezionato nella seconda fase, 2000); e l’ampliamento della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea (2001).
Progetto per via dei Fori Imperiali a Roma
Il progetto per la riqualificazione dell’area archeologica centrale di Roma, focalizzandosi in particolare su Via dei Fori Imperiali, si configura come un’opportunità straordinaria per esplorare la complessità e la ricchezza delle connessioni tra storia, architettura, urbanistica e cultura. Dalla sua inaugurazione nel 1932, Via dei Fori Imperiali è stata il teatro di conflitti tra diversi interessi, tra cui archeologia, architettura, urbanistica, simbolismi e ideologie.
Il nostro progetto aspira a sperimentare una metodologia capace di influenzare la scala più ampia della città e del paesaggio, riconoscendo il potenziale di plasmare e gestire il territorio attraverso il rapporto dinamico tra il sito e specifici dispositivi spaziali. La visione di fondo tiene conto della rilevanza storico-artistica del luogo, cercando di costruire relazioni che coinvolgano sia il presente che il passato. A livello territoriale, archeologia e infrastrutture emergono come temi dinamici che determinano la duplice natura lineare di Via dei Fori Imperiali. La nostra proposta suggerisce un sistema isotropo e bilanciato, collaborando con i siti storici e archeologici, nonché con il sistema territoriale verde circostante.
La strada, suddivisa in diverse aree, assume la forma di un museo all’aperto che ristruttura l’intero sistema archeologico su un unico livello accessibile al pubblico. La proposta di abbassamento verso il livello ipogeo rappresenta un punto di convergenza tra archeologia e infrastrutture, storia e geologia, memoria e oblio. Il nostro obiettivo è coinvolgere attivamente i visitatori nel processo di ricomposizione dei frammenti storici e nella narrazione del percorso attraverso la storia.
Per favorire la fruizione pubblica pedonale, la copertura proposta consiste in tettoie trasparenti sorrette da pilastri, creando piazze e spazi pedonali con aperture luminose che permettono di ammirare la camera sotterranea. Strutture essenziali e metalliche, flessibili e reversibili, fungono da elementi di base nel linguaggio architettonico, contribuendo a una legislazione urbanistica e creando un archivio di materiali riutilizzabili in tutte le aree archeologiche di Roma.
Riconosciamo l’importanza della documentazione, della storia e delle microstorie raccontate dai reperti, contribuendo così alla catalogazione e classificazione del patrimonio. Gli archivi e i laboratori, simbolo della filiera conoscitiva, sono destinati alla conservazione e allo studio dei reperti archeologici. Alla base della nostra proposta c’è l’obiettivo di integrare storia, architettura e cultura in un contesto contemporaneo, promuovendo la fruizione pubblica e la condivisione della conoscenza del patrimonio storico della città.



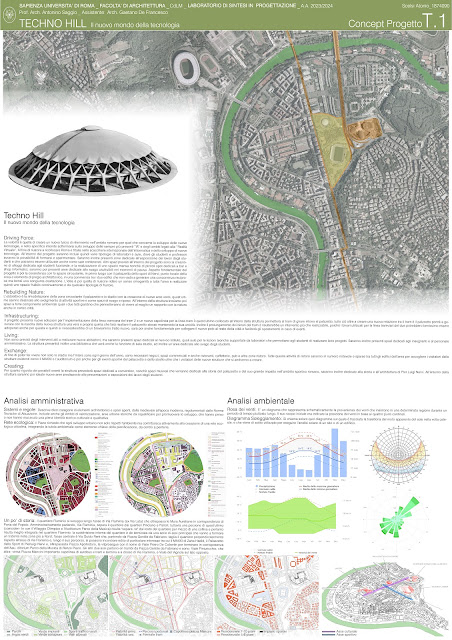


Commenti
Posta un commento